A 46 anni, Wallace scrisse un messaggio di addio di due pagine, corresse parte del manoscritto di Il re pallido e si impiccò a una trave di casa a Claremont, in California. Il corpo fu rinvenuto dalla moglie, Karen Green.
“VERSO OCCIDENTE L’IMPERO DIRIGE IL SUO CORSO”
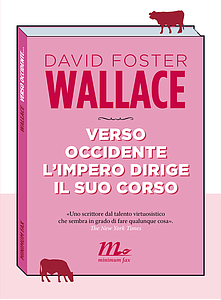 Tutti noi abbiamo piccole illusioni solipsistiche, spaventose intuizioni di una nostra assoluta singolarità: crediamo di essere gli unici della casa a riempire il contenitore dei cubetti di ghiaccio, gli unici a svuotare la lavastoviglie dai piatti puliti, gli unici a fare ogni tanto pipì nella doccia, gli unici ad avere un piccolo tic alle palpebre al primo appuntamento; di essere gli unici a prendere la nonchalance tremendamente sul serio; di essere solo noi a dare alle suppliche l’aspetto della cortesia; di essere solo noi a sentire il gemito patetico nello sbadiglio di un cane, il sospiro senza tempo nell’apertura di un barattolo ermeticamente sigillato, la risata sputacchiata qua e là in un uovo che frigge, il lamento in re minore nel rombo di un aspirapolvere; di essere solo noi a provare quando il sole tramonta lo stesso tipo di panico che un bimbo al primo giorno di scuola prova quando la mamma si allontana. Di essere solo noi ad amare i solo-noi. Di essere solo noi ad aver bisogno dei solo-noi. Il solipsismo ci tiene insieme, e J.D. lo sa. Sa che ci sentiamo soli in mezzo a una folla; senza fermarci a pensare a cosa ha dato vita a quella folla. Sa che siamo sempre volti in mezzo a una folla. E’ la sua passione.
Tutti noi abbiamo piccole illusioni solipsistiche, spaventose intuizioni di una nostra assoluta singolarità: crediamo di essere gli unici della casa a riempire il contenitore dei cubetti di ghiaccio, gli unici a svuotare la lavastoviglie dai piatti puliti, gli unici a fare ogni tanto pipì nella doccia, gli unici ad avere un piccolo tic alle palpebre al primo appuntamento; di essere gli unici a prendere la nonchalance tremendamente sul serio; di essere solo noi a dare alle suppliche l’aspetto della cortesia; di essere solo noi a sentire il gemito patetico nello sbadiglio di un cane, il sospiro senza tempo nell’apertura di un barattolo ermeticamente sigillato, la risata sputacchiata qua e là in un uovo che frigge, il lamento in re minore nel rombo di un aspirapolvere; di essere solo noi a provare quando il sole tramonta lo stesso tipo di panico che un bimbo al primo giorno di scuola prova quando la mamma si allontana. Di essere solo noi ad amare i solo-noi. Di essere solo noi ad aver bisogno dei solo-noi. Il solipsismo ci tiene insieme, e J.D. lo sa. Sa che ci sentiamo soli in mezzo a una folla; senza fermarci a pensare a cosa ha dato vita a quella folla. Sa che siamo sempre volti in mezzo a una folla. E’ la sua passione.
LA VITA – Il dramma di essere soli
 Dopo aver letto “Verso occidente l’impero dirige il suo corso”, Davide Foster Wallace mi ha convinto che in fondo siamo tutti malati di “soggettivismo”. Lo chiama “solipsismo”, o meglio, trae spunto da quello che dice la filosofia. La dottrina secondo cui “l’individuo pensante può affermare con certezza solo la propria esistenza”. Ma Wallace non si accontenta, amplia il significato, lo rende egoista e, a tratti, diabolicamente divino.
Dopo aver letto “Verso occidente l’impero dirige il suo corso”, Davide Foster Wallace mi ha convinto che in fondo siamo tutti malati di “soggettivismo”. Lo chiama “solipsismo”, o meglio, trae spunto da quello che dice la filosofia. La dottrina secondo cui “l’individuo pensante può affermare con certezza solo la propria esistenza”. Ma Wallace non si accontenta, amplia il significato, lo rende egoista e, a tratti, diabolicamente divino.
“Chi si crede di essere!”, è una di quelle frasi che tipicamente potrebbero essere usate per il solipsismo o, concedetemi, solipsista. Egocentrismo, presunzione e perdita della concezione di non essere il “centro del mondo”.
Wallace non ha remore nell’affrontare l’argomento, prendendo spunto da se stesso. Dalla facoltà che abbiamo in tanti di credere di essere venuti al mondo per concludere qualcosa di diverso, meraviglioso, sensazionale…”Unico”, pensando di avere uno scopo, che nulla accada per caso. Wallace mette “a tavola” il problema, quello che vedo farsi largo nell’era social, dove ognuno ha voglia, per forza, dire la sua. Per forza, ma non è detto che se ne abbia sempre la facoltà oggettiva. Ognuno ha il diritto di giudicare l’altro, ognuno ha la risposta, la verità da “donare” al mondo interno. Eppure parliamo di un lavoro scritto nel 1989. Quando Facebook, YouTube, Twitter e tanti altri social erano “fantascienza”. Trent’anni fa.
Cosa ne poteva sapere lo scrittore di come sarebbe diventato il mondo? La magia di quanto scrive sta nel fatto che analizza l’essere umano, proprio nella sua natura più spicciola, ridicola, schifosamente naturale. Egoista. Ecco.
Il comune essere umano, quello che ci guarda tutte le mattine mentre ci versa il caffè o incontriamo in metro con la musica pop nelle orecchie (o qualsiasi altra, per carità, non offendiamo nessuno), quello che ci siede accanto mentre aspettiamo il turno dal dottore. Lui, uno qualsiasi, di cui magari neanche ti accorgi. Sì, proprio quello, pensa inesorabilmente di essere venuto al mondo per un motivo speciale e rappresentare una rarità. Alcuni arrivano a convincersene a tal punto da mentire a se stessi e a farlo credere persino agli altri catturati dalla convinzione con cui se ne parla. Altri ci credono per un po’, ancora un altro po’, ci sperano, ma poi capiscono che non è così e perdono tutto. Demotivati, lasciati soli.
I migliori restano soli, ma non di una solitudine materiale, piuttosto spirituale, antitetica e meritoria. Pensateci. Tra le altre belle cose scritte da questo autore ce n’è una, che è pubblicata nella raccolta “Questa è l’acqua”, che parla della sua depressione ai tempi delle superiori e poi dell’università. Non aveva ancora scritto i suoi capolavori ma in questo racconto c’è già lo stile di chi non teme di entrare dentro le “cose brutte” narrandole con leggerezza e ironia.
QUESTA E’ L’ACQUA
 Prendo gli antidepressivi da, quanto sarà, un anno, e ritengo di avere i numeri per dire come sono.
Prendo gli antidepressivi da, quanto sarà, un anno, e ritengo di avere i numeri per dire come sono.
Sono straordinari, davvero, ma sono straordinari come sarebbe straordinario vivere, che so, su un altro pianeta caldo e comodo fornito di cibo e acqua fresca: sarebbe straordinario, ma non sarebbe la cara vecchia Terra.
Ormai è quasi un anno che non sto sulla Terra, perché sulla Terra non me la cavavo troppo bene. Diciamo che me la cavo un po’ meglio dove mi trovo adesso, sul pianeta Trillafon, con grande piacere, credo, di tutti gli interessati.
IL SUPPLIZIO – Che ironia questa depressione
Oggi si sente parlare di Foster Wallace soprattutto come “quello scrittore depresso che si è suicidato poco prima di pubblicare il suo ultimo romanzo”, e non come una delle voci più affascinanti, brillanti e multiformi di tutta la letteratura americana del Novecento.
Sulle orme di Pavese e Hemingway morì d’estate. Biografie, film e romanzi postumi continuano a parlarci del suo pensiero paradossale che in un vortice psicologico l’ha reso vittima e carnefice di se stesso. Il suo genio germogliava di creazioni splendide, vittime del dolore interiore. Wallace era in una gabbia dorata dove ogni riga delle 1400 pagine di Infinite Jest rappresentava una frustata inflitta al proprio corpo. Non c’era pace, solo supplizio dall’ inizio alla fine.
Il suo peccato? La sua anima, troppo candida per vivere. David Foster Wallace è stato un grande scrittore americano. Tra gli altri riconoscimenti, venne definito dal New York Times «la migliore mente della sua generazione», vinse una borsa di studio MacArthur (anche chiamata “sovvenzione per geni”) e Il Re Pallido, romanzo postumo,fu nominato nel 2012 tra i finalisti per il Pulitzer, quell’anno non assegnato.
Cosa mancava? Wallace amava la matematica e il tennis: la prima gli produceva «un’evocazione catartica della nostalgia di casa» (le linee rette e curve degli orizzonti topografici del Midwest), mentre il secondo, «gioco di soluzioni infinite in uno spazio finito», era per lui una delle massime espressioni della bellezza umana.
Cosa gli mancava, veramente? Si laureò all’Amherst College in letteratura inglese e filosofia, con una tesi di logica modale e matematica, ma solo la letteratura, a detta sua, era in grado di impegnargli il cervello al 97 percento. Così, a soli 24 anni, scrisse il suo primo romanzo, La Scopa del Sistema, che lo consacrò come uno degli scrittori più promettenti nel panorama statunitense. Inizia un dottorato in filosofia ad Harvard, ma dopo pochi mesi viene ricoverato alla clinica psichiatrica McLean’s di Boston. L’esperienza verrà trasfigurata in Infinite Jest, dove alcuni dei protagonisti vivono nella casa di recupero per tossicodipendenti Ennet House, luogo che si contrappone all’altro polo chiave del romanzo, l’accademia tennistica Enfield, dove agonismo e competizione la fanno da padroni. È paradossalmente la clinica di recupero il luogo chiave in cui emerge l’importanza di valori come la pietà e la compassione. Infinite Jest viene pubblicato nel 1996 ed è unanimemente considerato il suo capolavoro. Il Time lo ha incluso nei 100 migliori romanzi in lingua inglese pubblicati dal 1923 al 2006.
Quando si parla di David Foster Wallace sono due le parole sulla bocca di tutti: postmodernismo e depressione. Se sulla prima ci sarebbe molto da discutere – Foster Wallace non si riteneva postmoderno, anzi pensava che il termine non avesse più valore -, sulla seconda non ci sono molti dubbi: lo scrittore più innovativo degli anni ’90 ha convissuto con la malattia per oltre vent’anni, malattia che alla fine l’ha portato a togliersi la vita. La sua opera, però, è molto di più dei suoi demoni.
Il critico Michiko Kakutani ha detto: «Sapeva essere triste, divertente, comico, commovente e assurdo. A volte anche tutto in una volta».
Forse è vero, a Wallace non mancava niente. Da solo era tutto, troppo. E per questo non c’è solipsismo che tenga.
IL RE PALLIDO
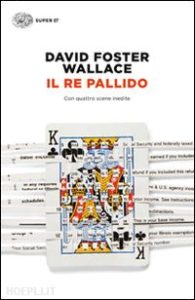 La nostra piccolezza, la nostra insignificanza e natura mortale, mia e vostra, la cosa a cui per tutto il tempo cerchiamo di non pensare direttamente, che siamo minuscoli e alla mercè di grandi forze e che il tempo passa incessantemente, e che ogni giorno abbiamo perso un altro giorno che non tornerà più e la nostra infanzia è finita e con lei l’adolescenza e il vigore della gioventù e presto l’età adulta, che tutto quello che vediamo intorno a noi non fa che decadere ed andarsene, tutto se ne va e anche noi, anch’io, da come sono sfrecciati via questi quarantadue anni tra non molto me ne andrò anch’io, chi mai avrebbe pensato che esistesse un modo più veritiero di dire “morire”, “andarsene”, il solo suono mi fa sentire come mi sento al crepuscolo di una domenica d’inverno.
La nostra piccolezza, la nostra insignificanza e natura mortale, mia e vostra, la cosa a cui per tutto il tempo cerchiamo di non pensare direttamente, che siamo minuscoli e alla mercè di grandi forze e che il tempo passa incessantemente, e che ogni giorno abbiamo perso un altro giorno che non tornerà più e la nostra infanzia è finita e con lei l’adolescenza e il vigore della gioventù e presto l’età adulta, che tutto quello che vediamo intorno a noi non fa che decadere ed andarsene, tutto se ne va e anche noi, anch’io, da come sono sfrecciati via questi quarantadue anni tra non molto me ne andrò anch’io, chi mai avrebbe pensato che esistesse un modo più veritiero di dire “morire”, “andarsene”, il solo suono mi fa sentire come mi sento al crepuscolo di una domenica d’inverno.
Woah, che bel post!